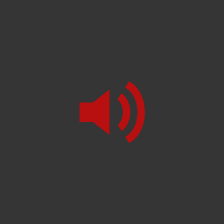-

Lecco. Vespri - Angelo Rusconi
-
Premana (LC). Mysterium Ecclesiae
Cantori di Premana
-
Premana (LC). Stabat Mater
Cantori di Premana
-
Premana (LC) Magnificat
Cantori di Premana
-
Premana (LC). Te Deum
Cantori di Premana
-
Premana (LC). Vexilla Regis
Cantori di Premana
-
Premana (LC). Pange lingua
Cantori di Premana
-

Agliate (MB). Basilica dei Santi Pietro e Paolo. Vespri - Angelo Rusconi
-

Agliate di Carate Brianza (LC). Manoscritto - Angelo Rusconi
-

Brentana di Sulbiate (LC). Biblioteca Chiesa di Sant'Antonio. Manoscritto. Antifonario Sec. XVI - Angelo Rusconi
-

Introbio (LC). Chiesa di Sant'Antonio Abate. Libro di canto manoscritto e stampa - Angelo Rusconi
-

Due Cossani (VA). Te deum. Manoscritti Archivio Privato Piergiorgio Busnelli - Angelo Rusconi
-

Due Cossani (VA). Ufficio e Messa per i Defunti. Stampe Archivio Privato Piergiorgio Busnelli - Angelo Rusconi
-

Due Cossani (VA). Ave Maria - Maestro Zuccoli. Stampe Archivio Privato Piergiorgio Busnelli - Angelo Rusconi
-

Clivio (VA). PArrocchia SS. Pietro e Paolo. Manoscritto - Angelo Rusconi
-

Cannobio (VB). Basilica di S. Vittore. Teoria musicale: Toni e Inni - Angelo Rusconi
-

Seregno (MB). Aechivio Basilica S. Giuseppe. Magnificat - Angelo Rusconi
-
Pieve di Incino. Orsenigo (CO). Vespri II Domenica di Quaresima
Angelo Rusconi
-
Primalina (LC). Vespri
Corale di Primaluna
-
Tremenico (LC). Stabat Mater
Corale di Tremenico
-
Tremenico (LC). Pange lingua
Corale di Tremenico (LC)
-

Vespri secondo l'antico rito Ambrosiano a Somasca - Elisa Piria
-
2011
2012
Canto liturgico di tradizione orale nelle aree di rito ambrosiano
Nella diocesi di Milano e in alcune altre aree della Lombardia e del Canton Ticino la messa e l'ufficio divino sono celebrati secondo il rito detto 'ambrosiano' o più propriamente 'milanese'. Alla liturgia milanese corrisponde un repertorio musicale, detto anch'esso 'canto ambrosiano' o 'milanese' (così come il canto gregoriano è il canto della liturgia romana), le cui fonti musicali più antiche conosciute risalgono al sec. XII. Naturalmente la pratica rigorosa del repertorio liturgico ufficiale è ed era possibile solo là dove esistessero scholae di cantori specializzati. Nelle parrocchie minori, soprattutto rurali e montane, il compito del canto era affidato alla comunità stessa; perciò, a un nucleo base-di melodie ambrosiane semplici, si è affiancato un repertorio di formule musicali e melodie che permetteva alle comunità di cantare i testi della preghiera liturgica.
Le melodie 'ufficiali' subirono un processo di inculturazione che le adattò al modo di cantare e alla sensibilità musicale popolare; le altre furono composizioni nuove, più moderne, adatte ad essere facilmente apprese, che venivano anch'esse rielaborate e ripresentate nei modi tipici del canto popolare. Va sottolineato che l'indagine sul rapporto fra repertori scritti e non scritti è molto delicata e complessa, anche perché lo stesso canto ufficiale, pur essendo copiato nei libri di canto, veniva praticato riferendosi più alla consuetudine che attenendosi strettamente a modelli scritti (tanto più che l'Antifonario ambrosiano non è mai stato edito a stampa prima del xx secolo e pertanto non è esistito un libro di riferimento ufficiale, se non per parti minoritarie del repertorio come gli inni).
Ancora più complesso da valutare è l'apporto creativo popolare al di fuori dei modi performativi: diverse testimonianze attestano che chi aveva attitudine e familiarità col canto poteva estemporaneamente proporre dei moduli melodici semplici per intonare testi ripetitivi come le litanie. In generale, comunque, utilizziamo la qualifica 'popolare' per indicare sia che si trattava di musica diffusamente praticata, sia che era trasmessa ed eseguita in modo analogo alla musica profana popolare.
È chiaro che il repertorio si è stratificato nel corso di secoli, secondo il processo di 'tradizione e rinnovamento' che ha sempre caratterizzato l'organico sviluppo della liturgia e della sua musica fino alla 'rivoluzione' post-conciliare; quanto oggi possiamo documentare è l'ultimo stadio, quello esistente nel momento in cui entrò in vigore la nuova liturgia creata dopo il Concilio Vaticano II, che pose fine alla pratica del canto liturgico tradizionale. Vi sono però casi in cui la comparazione fra testimonianze manoscritte più antiche e moderne registrazioni sul campo consente di gettare lo sguardo all'indietro, su epoche di cui non possediamo documentazione sonora. Fonti scritte preziose sono i libretti manoscritti che gli organisti vergavano per proprio uso, annotando i toni popolari che dovevano accompagnare: si tratta di documenti che ci danno informazioni sul canto liturgico popolare in epoca precedente alle più antiche registrazioni sonore.
Se l'apprendimento e la trasmissione del canto liturgico avveniva per consuetudine, un preciso sistema ne governava la prassi. Per intonare i testi propri (quelli che variano a ogni celebrazione) si utilizzavano semplici formule standard, caratterizzate da una struttura di tipo salmodico, di conseguenza adattabile facilmente a qualsiasi testo. I testi ordinari (quelli che restano invariati o sono frequentemente ripetuti) ricevono una veste musicale più ricca ed elaborata.
Allo stadio attuale, constatiamo che nel repertorio sono confluite: a) melodie ambrosiane; b) toni recenziori per i salmi e i cantici; c) melodie di varie epoche, appartenenti al genere del cantus fractus; d) composizioni d'autore più recenti.
Riguardo alle melodie ambrosiane, nelle esecuzioni popolari si rilevano varianti melodiche, abbreviazioni dei melismi e loro ridistribuzione sulle sillabe accentate del testo, fenomeni comuni a molti manoscritti specialmente dall'epoca post-tridentina in avanti; ciò apre interessanti scenari di ricerca sul rapporto fra fonti orali e scritte, pur con le cautele di cui si è detto.
Grande interesse hanno i brani che si possono classificare come cantus fractus. Il canto fratto è un genere di canto liturgico scritto in notazione ritmico-proporzionale, i cui primi esempi risalgono al tardo Medioevo per arrivare fino all'età moderna. Lo stile cambia secondo le epoche; ciò che rimane costante è la semplicità di scrittura e di esecuzione, che lo rende adatto a essere eseguito da cantorie non professionali e anche dal popolo (ad esempio a Gurro, in Val Cannobina, l'intero paese canta ancora il Messone, un Ordinario della Messa completo in canto fratto). In territorio ambrosiano è diffuso in forme ritmicamente elementari; spesso prevede una seconda voce che procede parallela alla prima a intervallo di terza, come nella polivocalità spontanea dell'arco alpino. Si configura così, qui, come un vero e proprio repertorio di confine, trait d'union fra musica 'colta' e popolare, fra oralità e scrittura.
Gli inni possono utilizzare la melodia ufficiale o una melodia nuova in canto fratto; nel primo caso, essa viene quasi sempre ritmizzata, come si verifica anche nella tradizione scritta a stampa fin dal xvi secolo.
Di rado un canto appare identico ovunque. La stessa melodia può essere presente in diversi centri, ma con varianti che la rendono un unicum; perciò i canti sono percepiti come "propri" dalle singole comunità e ne costituiscono un fattore identitario. Le varianti interessano normalmente le ornamentazioni, con logiche simili a quelle che si riscontrano nei manoscritti gregoriani e ambrosiani (manoscritti che non a caso ─ come si è detto ─ riflettono la molteplicità delle tradizioni locali più che un modello unitario).
Nella performance, le caratteristiche tipiche sono l'emissione aperta e sonora e la polivocalità procedente per terze. Quest'ultima non era pertinenza di gruppi ristretti: chiunque partecipasse al canto si collocava spontaneamente nella fascia vocale più congeniale per dar vita a seconde e anche terze voci.
NOTIZIE STORICO-CRITICHE
Il canto liturgico di tradizione orale rappresenta un capitolo della storia della musica che normalmente non è presente né nei manuali della materia né negli inquadramenti della musica liturgica considerata all'interno della storia della liturgia. Da ciò risulta una prospettiva fortemente deformata, dal momento che assume a paradigma l'attività delle grandi istituzioni, che è di per sé 'straordinaria', e la legislazione ecclesiastica. Al contrario, è proprio il canto liturgico 'popolare' ad aver costituito per secoli il panorama sonoro più familiare alla maggior parte della popolazione nel contesto della pratica religiosa.
Lo stesso discorso vale per il tema della partecipazione alla liturgia, in particolare al canto comunitario. È assai diffuso il luogo comune che prima del Concilio Vaticano II le comunità cattoliche non fossero che mute spettatrici dei riti, escluse dalla celebrazione e dal canto; in realtà la partecipazione al canto era corale e la partecipazione alla liturgia giocata su modalità differenti da quelle odierne, fondate prima di tutto sulla comprensione letterale delle parole.
Va precisato che nel territorio ambrosiano il canto liturgico non è mai stato pertinenza esclusiva delle confraternite, bensì canto della comunità, giocato essenzialmente fra il sacerdote e il popolo. C'erano naturalmente i cantori, collocati di regola in presbiterio, che intonavano e si facevano carico dei brani del Proprio. Ma fondamentalmente il canto era compito comunitario.
APPRENDIMENTO E TRASMISSIONE
L'apprendimento avveniva spontaneamente per imitazione, frequentando la chiesa e le varie funzioni che punteggiavano l'anno liturgico; nella concezione post-conciliare la pratica liturgica si esaurisce quasi interamente con la Messa mentre in precedenza assai più ampio era il ventaglio di occasioni rituali che coinvolgevano la popolazione (Vespri, Compieta, processioni, momenti di preghiera comunitaria come la recita del Rosario e così via). In seguito ai controversi modi di realizzazione e soprattutto di applicazione delle riforme liturgiche promosse dopo il Concilio Vaticano II, nelle celebrazioni liturgiche è stata introdotta la lingua volgare e il latino è stato escluso in maniera quasi assoluta anche dal canto; inoltre la nuova liturgia ha profondamente mutato testi e strutture della forma precedente. Ciò ha comportato l'accantonamento forzoso del repertorio popolare preesistente, che, salvo occasionali sopravvivenze di qualche brano, è oggi ormai confinato alla memoria di alcuni anziani e pertanto a un passo dalla definitiva scomparsa là dove non si sia provveduto a documentarlo. Del tutto eccezionale è il caso della parrocchia di San Giorgio a Dorio, dove, grazie a uno zelante prevosto, si è continuato fino a tempi recenti a cantare l'Ufficio della Beata Vergine con i testi e le melodie tradizionali.
COMUNITÀ
I cori di alcune diocesi e gruppi corali spontanei hanno ripreso o re-imparato le melodie del repertorio liturgico di rito ambrosiano. In alcuni casi si sono costtuiti gruppi ex novo, come a Sartirana di Merate o a Casletto di Rogeno, costituiti sia dagli informatori anziani sia da giovani del luogo. Questi cori sono oggi chiamati a cantare nell'ambito di celebrazioni in rito tradizionale anche fuori dalla propria sede di residenza e praticano i canti anche nella nuova liturgia, immettendoli così nuovamente in funzione.
I principali gruppi corali sono:
Coro della parrocchia di San Giorgio a Dorio
Gruppo spontaneo di cantori di Premana, per convenzione etichettato come Cantà Promàn
Gruppo spontaneo di cantori di Sartirana di Merate, direttore Elena Redaelli
Coro della parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso a Cortenova, direttore Pietro Ossola
Coro della parrocchia di San Bartolomeo a Margno
Corale Santa Cecilia di Imberido, direttore Pasquale Frigerio
Coro della parrocchia di San Lorenzo a Vendrogno
AZIONI DI VALORIZZAZIONE
L'Associazione Res Musica – Centro ricerca e promozione musicale (Lecco) organizza celebrazioni e concerti per la valorizzazione del repertorio liturgico di rito ambrosiano. Si occupa di raccogliere documentazione sul canto liturgico e di rifunzionalizzare le cerimonie liturgiche che ne costituivano il contesto. A questo fine, si è reso necessario che i gruppi corali locali riprendessero o re-imparassero le melodie; in alcuni casi si sono costituitii anche gruppi ex novo.
MISURE DI SALVAGUARDIA
Il canto liturgico di tradizione orale in Lombardia nelle aree di rito ambrosiano fa parte del R.E.I.L. (Registro delle Eredità Immateriali Lombarde), progetto di valorizzazione, salvaguardia e promozione dei beni immateriali, saperi tradizionali e pratiche rituali della Regione Lombardia.
Per sapere di più
Siti web
Bibliografia
Premana. Ricerca su una comunità artigiana
Silvana Editoriale d'Arte 1979
Il canto liturgico di tradizione orale nella diocesi ambrosiana. Primi risultati di un’indagine in corso.
Fondazione Levi
I vespri di tradizione orale a Premana
Fondazione Levi 2014
Beni materiali
La ricerca ha portato alla luce un cospicuo numero di fonti liturgico-musicali manoscritte, mai segnalate né catalogate in precedenza: i fondi più consistenti si trovano nella biblioteca della Basilica di San Giuseppe a Seregno (MB) e a Cannobio (VB). Nella Parrocchiale di Introbio (LC) è stato rinvenuto un volume di canto liturgico com'era praticato agli inizi del '900. Vanno infine menzionati rari casi di registrazioni d'epoca, come un LP inciso nel 1984 a Carugate (Brianza) con un'ampia raccolta di brani che ci restituisce il 'suono' di una comunità che canta; alcuni pezzi sono accompagnati dalla banda, a testimonianza di una prassi un tempo assai diffusa.
A cura di
Res Musica - Centro ricerca e promozione musicale - Provincia di Lecco - Angelo Rusconi
Data di pubblicazione
27-NOV-2012 (Angelo Rusconi)
Ultimo aggiornamento
14-LUG-2015 (Fabia Apolito)
TweetDalla Community
Racconta